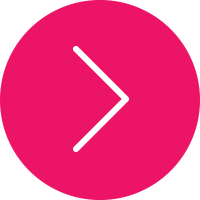Per mano sinistra
I mancini e la musica
Origini, strumenti, personaggi ed i più recenti studi neuroscientifici sul mancinismo in musica. Un fenomeno su cui resta ancora molto da scoprire
Una panoramica
Mentre provavo, entravano ogni tanto alcuni musicisti di jazz per ascoltare. Una sera, dopo aver suonato Bach a tutta velocità, uno di loro mi disse: “Ehi, ragazzo, tu hai una mano sinistra buona come la destra”. Gli ho risposto ridendo: “Fortunatamente sono mancino.
Questo aneddoto è uno dei tanti che appartengono al celebre Glenn Gould; durante uno dei suoi tour statunitensi in mancanza di uno strumento su cui esercitarsi, si vide costretto ad utilizzare un pianoforte di un malfamato jazz club, ovviamente nei momenti in questo era libero. La scena è ridicola ed al tempo stesso illuminante di come l'abilità di Gould facesse presa anche su musicisti abituati di certo alle spericolatezze "senza rete" delle improvvisazioni jazz. Spicca peraltro quel “fortunatamente”, che rimane come sospeso se si pensa per un attimo alle difficoltà quotidiane che i mancini conoscono molto bene, come maneggiare un apriscatole o un paio di forbici, o l’azione di aprire una finestra, gesti che richiedono normalmente l’uso della mano destra. Stride ancor di più se si pensa come anche nel lessico quotidiano, il termine "sinistro", riferito all'"altra mano" connota sempre un che di negativo, di sbagliato o peggio di infausto. Infatti "sinistro" è l'incidente stradale come pure un personaggio o una situazione oscura e gravida di cattivi presagi, mentre al contrario la “destrezza” indica abilità e capacità nel compiere un'azione. Se possiamo "destreggiarci" nello sport o nella vita quotidiana, dobbiamo porre attenzione al “tiro mancino”, di chi ci colpisce con astuzia o a tradimento. E se le parole hanno un significato, allora ancora oggi il mancino deve sopportare il disagio di chi per secoli si è visto discriminato (non solo con le parole) e costretto a “correggere il proprio difetto” in nome di una presunta norma.
I mancini del resto sono sempre esistiti, presumibilmente anche in passato dell'ordine del 10 per cento. Non stupisce dunque se, assieme ai pregiudizi, si colloca anche il senso di appartenenza ad un ristretto “club d’eccellenza”, che ha portato in passato mancini celebri a non nascondersi, anzi ad esibire in maniera eclatante, persino plateale, la propria “natura” come indice di genialità. E' noto che Michelangelo per scioccare i fiorentini si mettesse pubblicamente in piazza a scolpire con la sinistra ed a dipingere con la destra, come ad affermare una specie di supremazia, o la ormai celeberrima "scrittura allo specchio" di Leonardo da Vinci. Sappiamo però che arroccarsi nella “specie da difendere” è un gioco altrettanto pericoloso ed inutile quanto soffrire il pregiudizio!
La parola alla scienza
E' noto che il cervello umano è diviso approssimativamente in due emisferi, ognuno dei quali controlla la parte opposta del corpo a livello motorio. Fin dai pionieristici lavori di fine ‘800 si è visto che il linguaggio, le abilità logiche ed il pensiero analitico si ritrovano nell’emisfero sinistro del cervello, da cui deriva la dominanza della mano destra per la scrittura. Nell’emisfero destro invece sono collocate le capacità spaziali e visive, oltre alla percezione della musica. Questa suddivisione, grossolana per la verità, indica che i due emisferi sono “specializzati”, ognuno con compiti e funzioni distinte. In questa visione “classica” il mancino avrebbe un cervello speculare rispetto ad un destro, con tutte le funzioni capovolte. Gli studi più recenti, molti dei quali peraltro pochissimo noti anche da un pubblico per così dire "specializzato" hanno evidenziato un modello molto più sfumato, dove l'intera popolazione presenta un maggiore o minor grado di prevalenza per una o per l'altra mano, in proporzioni variabili, pur vedendo sempre una cospicua maggioranza di soggetti destri.
Sulle cause e le origini del fenomeno le tesi sono discordanti. Alcuni sostengono che il mancinismo sia dovuto a squilibri ormonali durante la gestazione che causerebbero un aumento del livello di testosterone ed un conseguente ritardo nello sviluppo dell’emisfero sinistro a vantaggio del destro, un’ipotesi, questa, lungi dall’essere dimostrata con certezza; il credito di cui ha goduto finora dipende dal fatto che un cervello destro più sviluppato favorirebbe un aumento delle abilità spaziali, visive e musicali, dando ragione a chi evoca una “superiorità artistica” del mancino, oltre a giustificarne una prevalenza percentuale tra i maschi.
Più accreditata dalla comunità scientifica è la teoria sviluppata da Marian Annett dell’Università di Leicester (UK) dove l’origine della manualità sarebbe dovuta ad un gene che causa lo spostamento verso l’emisfero sinistro dei centri linguistici, e, di conseguenza, anche la prevalenza della mano destra solo per la scrittura senza relazione alcuna con altre abilità. Questa tesi spiegherebbe anche il fatto che il linguaggio sembra una delle poche se non l'unica abilità umana ben localizzata (nell'emisfero destro o sinistro) e "specializzata". Lo spostamento quindi non corrisponderebbe necessariamente ad una predominanza totale di una parte del corpo sull’altra (“la preferenza precede la prestazione”, afferma Annett), per cui si può essere “mancini” anche solo per l’uso dell’occhio, dell’orecchio o del piede.
La presenza di questo gene risulta legata al calcolo delle probabilità, e la manualità deriva dalla combinazione di esso con altri fattori, anche ambientali. Annett calcola così un 64 per cento di soggetti che sono “fortemente destri” e solo il 4 per cento sono “fortemente mancini”. Il restante (più di un terzo del totale) “mischia le mani”, in altre parole oscilla tra una moderata preferenza per una mano o per l’altra. In più dimostra che solo i mancini “puri” mostrano i centri linguistici nell’emisfero destro, allo stesso modo di un 3 per cento circa di destri. Anche il fattore ereditario sembra ridursi dato che la percentuale di avere un figlio mancino con entrambi i genitori con la stessa caratteristica è solo del 26%, contro un 9,5% se in famiglia sono entrambi destri; in questa prospettiva il mancinismo si discosta da altri tratti trasmissibili per via genetica, come il colore degli occhi o della pelle, e, come vedremo, risulta influenzabile anche da elementi ambientali post-natali.
Le differenze a livello neurologico non riguardano solo il linguaggio. Le moderne tecniche d’indagine clinica ci permettono di comprendere come ad una diversa organizzazione cerebrale può corrispondere un modo differente di “sentire” e di produrre musica. Studiando i musicisti con la Risonanza Magnetica Funzionale e la Tomografia ad Emissione di Positroni (PET) si è scoperto che la pratica di uno strumento musicale fin dalla tenera età provoca un aumento in volume di alcune zone cerebrali, a cui corrisponde una “ristrutturazione” del cervello e ad un sostanziale equilibrio tra i due emisferi. Ad esempio, vi è un ingrossamento del corpo calloso, un fascio di nervi che permette lo scambio di informazioni motorie tra le due metà del cervello, come pure della parte superiore sinistra del lobo temporale, detta planum temporale e sede del cosiddetto “orecchio assoluto”. Soprattutto vi è un potenziamento generale di tutte le aree motorie della mano “non dominante”, oltre che di quelle legate alla percezione musicale.
E i musicisti?
Se la scienza ci offre un modello di manualità predominante graduale, nel momento della produzione musicale, ovvero della pratica su uno strumento, possono corrispondere strategie esecutive diverse. L’avventura recente della musica rock ci mostra un “effetto ribaltamento” da parte di alcuni musicisti che capovolgono lo strumento. Ad esempio, se osserviamo gli strumenti a corde, come chitarra e basso elettrico, abbiamo Paul McCartney che, rovesciando tutte le corde, si trova ad avere uno strumento assolutamente speculare; diversamente un altro celebre mancino, Jimi Hendrix operò una scelta ancora più drastica, imbracciando una chitarra "destra" semplicemente al contrario ma senza cambiare l'ordine delle corde, ritrovandosi così le corde acute al posto delle gravi; ciò lo ha portato a sviluppare una tecnica molto particolare e assolutamente originale. Per venire incontro ad un pubblico più esigente, l’industria degli strumenti si prodiga già da diversi anni a produrre chitarre elettriche e bassi elettrici già “pronti all’uso”, riconoscendo il fenomeno ed includendo così anche una buona fetta di popolazione in precedenza ignorata. Per altri strumentisti, come ad esempio i batteristi, il problema si risolve semplicemente ribaltando specularmente tutti i pezzi dello strumento. Ma se il capovolgimento “a specchio” pare essere una scelta conveniente, non tutti la condividono; infatti, molti chitarristi (e batteristi) mancini suonano con lo strumento in posizione normale, mentre altri ribaltano la chitarra, ma non le corde, come Hendrix. Capita poi che a volte il rovesciamento non viene nemmeno contemplato, sia a causa di usi o tradizioni scolastiche consolidate o solo per colpa di un insegnante poco sensibile. E’ il caso dei violinisti, o più in generale degli strumentisti ad arco, che forse gradirebbero poter tenere l’archetto nella mano “forte”; pur nella concezione che il ribaltamento parrebbe essere la scelta più logica, come dimostra l’esistenza, almeno nei paesi anglosassoni, di metodi di didattica per il violino left-handed, quasi mai troviamo un mancino in orchestra con lo strumento rovesciato, ed uno dei motivi, anche se non l’unico, sembra essere quello di dover osservare (orrore!) un musicista girato al contrario. C'è anche il rischio (concreto!) che un violinista che imbraccia l'archetto con l'altra mano rischi di infilarlo negli occhi del compagno di leggio, e questo è un altro limite.
Se adesso andiamo al pianoforte, ci si rende subito conto che è uno strumento che non è mai stato considerato "destro" o "mancino", in virtù del fatto che le due mani sono per così dire entrambe "specializzate" in un compito preciso. Gli studi neurologici ci dicono che un moderato mancinismo porta al miglioramento di una particolare abilità, come dimostrato dal dottor Reinhard Kopiez dell’Università di Hannover. Egli ha sottoposto alcuni musicisti ad esame radiologico durante l’esecuzione di brani musicali “a prima vista”, ovvero nel momento esatto in cui li leggevano per la prima volta, riscontrando che compiono complessivamente meno errori coloro che mostrano un minor grado di asimmetria cerebrale. Non è dato sapere oggi con certezza se è lo studio del pianoforte a favorire l’equivalenza emisferica, con il mancinismo come “effetto collaterale” o se, al contrario, questa favorisce la pratica pianistica.
Gettando uno sguardo al passato, il secondogenito di Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel, è il primo musicista nonché pianista di cui abbiamo certezza del suo mancinismo. Il suo poderoso trattato per lo studio del clavicembalo, il Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (trad. it.: Saggio sull’interpretazione della musica barocca), oltre ad essere la summa della didattica paterna, è una testimonianza evidente del suo mancinismo; lungo tutto il trattato, Emanuel ci conduce, con dovizia di esempi ed esercizi, alla scoperta ed alla comprensione della mano sinistra ponendola di fatto sullo stesso piano dell’altra. Di molti altri, tra cui Mozart, Beethoven, Chopin, Rachmaninoff, Prokof’ev, Ravel, abbiamo notizie poco certe di una presunta appartenenza alla schiera dei mancini, se non addirittura fasulle. Più recentemente troviamo invece molti nomi, anche importanti, nell’ambito jazz, tra cui il compositore Cole Porter, i pianisti Bill Evans, Errol Garner e McCoy Tyner, anche se è il mondo del rock a mostrare il maggior numero di musicisti mancini, soprattutto chitarristi e batteristi.
Mancini si nasce, ma a volte lo si diventa: è il caso arcinoto del pianista austriaco Paul Wittgenstein (1887-1961) che, perso il braccio destro nella Grande Guerra, non si diede per vinto, adattando quasi tutto il suo repertorio per la mano rimasta e divenendo ispiratore di composizioni, alcune di notevole valore, come i Concerti per la sola mano sinistra di Ravel e Prokof’ev (entrambi nella “lista”), Diversion di Benjamin Britten, il Preludio e Notturno op. 9 di Skrjabin, e altri. Meno conosciuta ma degna di nota ugualmente, la storia di Leon Fleischer, che per molti anni si è trovato inabile con la destra, ed in qualche modo ha ripercorso la carriera del suo illustre predecessore,essendo anch'egli interprete mirabile di quel repertorio.
Altre volte suonare con la sola mano sinistra evoca emozioni particolari: “C’è un solo modo con cui posso assicurarmi un piacere infinito da questo pezzo … quando lo suono con la sola mano sinistra! Lo stesso tipo di difficoltà, la qualità della tecnica, il fluire degli arpeggi, tutto converge a darmi l’impressione di essere un violinista”. Così scrive Johannes Brahms nella lettera che accompagnava l’omaggio all'amata Clara Schumann della sua trascrizione della Ciaccona per violino di Bach.
Per indagare sulla reale influenza che la manualità ha sull’esecuzione musicale, ci si deve interrogare sulla natura stessa dello strumento. Infatti si hanno percentuali più alte di mancini tra i fiati (sia “legni” che “ottoni”) che non tra gli archi, mentre il pianoforte si ritrova escluso da qualsiasi considerazione statistica.
Il Pianoforte è uno strumento ambidestro?
Paradossalmente, pur presumendone una sua natura “ambidestra”, eso sembra essere uno strumento musicale poco comprensibile per i mancini. Lutz Jancke, neuropsicologo dell’Università di Zurigo, afferma, infatti, che la mano dominante ha un impatto decisivo sulla comprensione della musica; pertanto, data la conformazione della tastiera, i destri sono più portati a privilegiare la melodia, lasciando alla sinistra un ruolo subalterno di accompagnamento. Al contrario, chi è predisposto per porre più attenzione alla mano sinistra, può mostrare una sensibilità particolare per le relazioni armoniche rispetto alla melodia, e non solo al mero dato meccanico di maggior pressione sui tasti con la “mano forte”.
Forse oggi possiamo vedere sotto un’altra luce i commenti salaci, che allora apparivano solo come delle provocazioni, con cui Glenn Gould liquidava (anche con qualche stortura) tutto la letteratura pianistica del primo romanticismo, che sappiamo essere basato in gran parte su melodie accompagnate: “Un altro aspetto di questa musica… sta nel fatto che Schubert, Chopin, Schumann volevano credere o far credere che il pianoforte è uno strumento omofonico. Ora, ciò è falso: secondo me il pianoforte è uno strumento per il contrappunto...” sosteneva infatti Gould, mentre alla luce di queste scoperte possiamo ipotizzare una reale mancanza di comprensione da parte del pianista canadese di quel repertorio. Jancke sostiene che per com’è progettata la tastiera questa causi al mancino delle difficoltà all’inizio della pratica scoraggiandolo nel proseguirne gli studi, e questo sarebbe all'origine di una prevalenza di pianisti destri. La soluzione "mancina" starebbe nel cosiddetto “pianoforte rovesciato”, uno strumento che presenta una tastiera speculare, con i gravi a destra e gli acuti a sinistra, il che permetterebbe al mancino un controllo maggiore da parte della mano dominante. Jancke giunge a questa conclusione studiando il pianista e concertista Christopher Seed, il quale ha ideato e sperimentato questo tipo di strumento su se stesso. Le radiografie effettuate sul suo cervello durante l’esecuzione di composizioni di vario genere, evidenziano che il pianoforte rovesciato provoca una maggiore attivazione dei centri motori e musicali, che per Seed sono collocati entrambi nell’emisfero destro, rispetto allo strumento tradizionale. Questi risultati riguardano solo un soggetto, con un modello di lateralizzazione molto particolare, anche se un altro studio dell’Università di Harvard ci porta una parziale conferma. Infatti un campione composto da giovani pianisti, principianti e non, alle prese con entrambi gli strumenti mostra che il pianoforte rovesciato è preferibile per i mancini, almeno per chi comincia la pratica.
Essendo l’argomento ancora poco indagato è presto per trarre conclusioni certe. Del resto una pratica costante con lo strumento tradizionale può portare al superamento delle difficoltà iniziali, creando alla fine i presupposti per una diversa (e forse più allargata) comprensione della musica. D'altronde l'utilizzo dello strumento rovesciato, nonostante lo scambio delle parti tra le due mani, mantiene inalterata la diteggiature a e solo scambia i ruoli delle due mani, quindi non pregiudica, almeno apparentemente, la lettura della partitura tradizionale; questo è forse il motivo che ha permesso al mancino Seed di raggiungere velocemente elevate prestazioni sul nuovo strumento. Chissà se Glenn Gould lo avrebbe apprezzato!